
Introduzione alla filosofia indiana:
i sei darshana
***
LE
RADICI DEL PENSIERO FILOSOFICO
di Michel Hulin
I SISTEMI FILOSOFICI DELL'INDIA
MÌMÀMSÀ -VEDANTA -SÀMKHYA
YOGA – VAISESICA - NYAYA
DOMANDA: Che cosa
sono i dashana?
I darçana sono la filosofia dei bràhmani e costituiscono
l'espressione filosofica della casta bràhmanica, al tempo stesso
nella sua diversità apparente e nella sua unità profonda, ma per
comprendere bene di che si tratta, forse è opportuno fare un breve
richiamo storico. Riportiamoci un istante col pensiero a un'epoca
situabile all'incirca verso l'inizio dell'era cristiana. A
quell'epoca i movimenti religiosi, che si sono sviluppati intorno a
un nucleo monastico, come il buddhismo e il jainismo, già da
parecchi secoli hanno costruito grandi monasteri, con annesse
scuole, hanno istituito regole di discussione e grazie ad esse hanno
elaborato una terminologia tecnica, una concettualizzazione
relativamente affinata.
Per contro, dal lato del bràhmanesimo, la situazione è
caratterizzata dall'esistenza di una vasta letteratura, ma sempre
essenzialmente religiosa: tutto il corpus vedico, da un lato,
comprese le Upanishad e, dall'altro, la letteratura speculativa, che
si innesta sulle grandi epopee, il Mahàbhàrata, in particolare, di
cui la celebre Bhagavad Gìtà non è che un frammento, e altri testi
ancora. In tutta questa letteratura noi troviamo naturalmente molti
materiali per una possibile filosofia, cosmogonie, identificazioni
mistiche tra il sacrificio, la persona e il cosmo, racconti di
esperienze spirituali, miti soteriologici di ogni tipo, ma ciò che
manca ancora è la concettualizzazione, la ricerca di una certa
sistematicità, la produzione delle prove, sicché i bràhmani, a una
certa epoca, hanno dovuto avvertire questa mancanza, e si può
pensare che i darçana si sono formati sulla base dei sùtra - quei
versetti mnemonici, che sono come i segnavia di una dottrina - e che
si sono costituiti a una data che non è possibile fissare con troppa
precisione, ma che per ciascuno di loro si colloca circa all'inizio
dell'era cristiana.
DOMANDA: Come prendono forma i darshana?
La genesi dei darçana è assai singolare e rivelatrice. Bisogna dire
innanzi tutto che il termine stesso darçana si può tradurre
letteralmente con "modo di vedere" o "punto di vista". Dapprima i
darçana sono dei punti di vista particolari sulla realtà, che, in
quanto tali, non sembrano escludersi reciprocamente, ma piuttosto
essere complementari. Ora, questa relazione di complementarità, che
più tardi, in età classica, costituirà un problema, è propria dei
darçana ai loro inizi, ciascuno dei quali sembra incominciare sotto
il segno di una tecnica particolare.
Per fare un esempio di darçana, di cui parlerò piu' avanti, la
mìmàmsà, che è una specie di esegesi del rituale, è cominciata
appunto nel prolungamento delle esegesi vediche antiche, come un
metodo sistematico per interpretare i testi vedici, piuttosto che
affidarsi all'ispirazione individuale.
Un altro esempio è il Nyàya, letteralmente "metodo per dirigere il
pensiero", che ha preso forma sotto le specie di una determinazione
più precisa dei criteri ai quali ogni ragionamento doveva soddisfare
per essere accettabile, cioè non comportare contraddizioni e
produrre la persuasione negli uditori cui era destinato. E' evidente
che il Nyàya all'origine non si spiega che nella prospettiva di
dibattiti essenzialmente orali, che i bràhmani sempre più dovevano
sostenere contro i rappresentanti di filosofie esterne al loro
ordine, essenzialmente i buddhisti e i "jaina", di cui ho già detto
che erano in vantaggio su di loro, da questo punto di vista.
Si potrebbero moltiplicare gli esempi: ogni volta ritroviamo lo
stesso fenomeno. Allora l'evoluzione successiva è stata questa:
muovendo da un inizio relativamente tecnico e specializzato, ogni
darçana secondo una necessità iscritta nella cosa stessa, cioè
secondo la naturale interconnessione di tutti i problemi della
filosofia, ogni darçana dunque si è esteso molto al di là dei suoi
interessi iniziali.
Per esempio il Nyàya non si è accontentato di restare una semplice
logica, è diventato una teoria della conoscenza, una psicologia,
perfino un'etica e la stessa evoluzione si è prodotta per ogni altro
darçana. Dunque a poco a poco in un intervallo di due, tre o quattro
secoli, i darçana sono diventati delle filosofie a pieno titolo e da
quel momento era inevitabile che entrassero in conflitto gli uni con
gli altri. La loro complementarità iniziale è stata un po'
obnubilata ed entriamo con il V, VI e VII secolo, in quella che è
considerata l'età d'oro del pensiero filosofico indiano, l'età in
cui infuria il dibattito filosofico, da una parte dei darçana fra
loro, dall'altra dei darçana che fanno fronte comune contro gli
avversari esterni, buddhisti, "jaina" e scuole materialistiche. Ecco
in prima approssimazione la linea evolutiva dei darçana, almeno
nell'età classica.
DOMANDA: Ci può illustrare i contenuti dei
darçana, a cominciare dalla prima coppia, Mìmàmsà e Vedanta?
Sì, lei parla di coppia. Per capire questa espressione non sarà
inutile una breve messa a punto storica. Si riscontra infatti che un
po' più tardi nel tempo, "grosso modo" intorno all'inizio del II
millennio della nostra era, il dibattito filosofico ha cominciato a
rinnovarsi, in modo meno evidente che per il passato, nel senso che
le posizioni dottrinali si sono fissate e d'altronde i grandi
avversari dei bràhmani, che a lungo avevano stimolato la loro
inventività speculativa, cioè i buddhisti, per ragioni storiche, che
non posso prendere in esame qui, sono scomparsi dalla scena. A quel
punto i bràhmani si sono ritrovati praticamente senza interlocutori
esterni e a poco a poco si è fatta strada l'idea che c'era in comune
tra loro più di quanto non fosse apparso nelle epoche anteriori.
Si entra allora in una età più propriamente scolastica, in cui
predomina la sistematizzazione, in cui si classificano le dottrine
per affinità, e assai presto si è imposta una classificazione dei
darçana in sei sistemi fondamentali o piu' esattamente in tre gruppi
di due sistemi ognuno, cioè da una parte il Sàmkhya e lo Yoga,
dall'altra la Mìmàmsà e il Vedanta e infine il Nyàya e il Vaisesika.
E' a cominciare dal XII, XIII secolo circa, che questo modo di
considerare i darçana è diventato in un certo senso canonico. Più
tardi ancora, d'altronde, i bràhmani cominceranno a produrre testi
in una certa misura paragonabili alle nostre enciclopedie o alle
nostre storie della filosofia, cioè passeranno in rivista tutte le
dottrine filosofiche possibili, classificandole in un ordine di
adeguazione crescente alla verità. Quindi metteranno in basso le
dottrine estranee al loro universo bràhmanico, materialistiche,
"jaina", buddhistiche, eccetera, e i darçana stessi saranno
classificati in un ordine gerarchico, culminante nel vedanta,
considerato a quell'epoca come il più bel fiore, come il compimento
insuperabile del pensiero bràhmanico. Questa è la cornice. Partendo
di qua possiamo addentrarci nel contenuto dottrinale proprio di
ciascun darçana.
DOMANDA: Consideriamo dunque la prima
coppia: Mìmàmsà e Vedanta.
Sì, io penso che è abbastanza logico considerare, come prima coppia,
quella formata dalla mìmàmsà da un lato e dal vedanta dall'altro.
Bisogna dire d'altronde che la mìmàmsà e il vedanta sono considerati
l'una come la "mìmàmsà antica" o "prima mìmàmsà" e l'altro come
"seconda mìmàmsà" o "mìmàmsà ulteriore". Ciò che hanno in comune
essenzialmente è il riferimento quasi esclusivo al Veda,
all'autorità del Veda.
Si presentano entrambe come esegesi del corpus vedico, semplicemente
con una diversa specializzazione, di cui renderemo conto in seguito.
In ciò che concerne la mìmàmsà in senso proprio o "prima mìmàmsà",
la sua genesi si situa sul diretto prolungamento di interpretazioni
dei testi vedici, di cui i bràhmani avevano pratica già da parecchi
secoli. Ma vengono introdotte alcune regole del gioco,
sistematizzate le pratiche anteriori. A questo scopo la mìmàmsà si
dedica a un immenso lavoro di classificazione degli enunciati del
Veda. Ritenendo che l'intero corpus vedico possa essere analizzato
in diversi tipi di enunciati, come per esempio "vidhi", cioè le
prescrizioni, "sedha", le interdizioni, le denominazioni, i mantra,
cioè le formule rituali e infine i testi esplicativi delle
ingiunzioni e delle interdizioni. In un certo senso, è vero, questo
minuzioso lavoro di analisi del testo vedico non è ancora di per sé
filosofia, ma lo diventa a poco a poco, grazie alle discussioni,
alle polemiche che la mìmàmsà è portata a sviluppare contro le altre
scuole. In particolare ciò che la spinge a quelle polemiche è il suo
principio fondamentale, secondo cui il Veda è una entità eterna, che
non ha bisogno di essere rivelata da una figura divina, che in
qualche modo si autorivela. E questo porta la mìmàmsà alla
straordinaria e singolarissima tesi del carattere naturale ed eterno
dei suoni del Veda. Beninteso si tratta di una affermazione del
tutto trascendente rispetto ai limiti dell'ordinaria esperienza
sensibile. La mìmàmsà deve costruire allora una specie di metafisica
della parola, nei termini della quale si sforza di far comprendere
come l'enunciazione temporale, in successione, delle parole vediche
da una parte, e dall'altra la nostra comprensione di quelle parole,
che si sviluppa a poco a poco, nell'ordine del tempo, non
contraddice a una specie di presenza statica e massiccia e integrale
dei suoni del Veda.
La mìmàmsà è dunque portata a una riflessione sulle strutture, sui
meccanismi ontologici, si potrebbe dire, che intervengono perchè non
sia rivelato della totalità dei suoni del Veda, presente ad ogni
istante, se non ciò che è immediatamente utile a colui che pronuncia
o a colui che ascolta e comprende determinate parole vediche.
Quest'idea l'ha portata ad ogni sorta di polemiche sul linguaggio in
generale, da una parte con altre scuole bràhmaniche, come il Nyàya,
di cui parleremo piu' avanti, e dall'altra con le scuole
extra-bràhmaniche, che non ammettono affatto quei presupposti.
Dunque in questo modo la mìmàmsà è condotta, forse contro le sue
stesse intenzioni, a costituire una dottrina di ciò che poi si è
chiamato dappertutto i "pramana", cioè le norme della retta
conoscenza. Allora naturalmente, se per essa il Veda è il "pramana"
per eccellenza, la conoscenza retta per eccellenza, la mìmàmsà deve,
malgrado tutto, far posto a ciò che ci dà accesso, alle forme, per
così dire, mondane o empiriche della conoscenza, in primo luogo alla
percezione, e poi all'inferenza fondata su dati della percezione, e
poi ancora ad altri mezzi di conoscenza, che essa distingue, come la
supposizione necessaria, la constatazione d'assenza, eccetera.
Noi non possiamo entrare nei particolari di queste discussioni della
mìmàmsà. Ciò che possiamo tener fermo è che, al di là della sua
specificità, essa ha gettato le basi di una teoria della conoscenza,
di una teoria del linguaggio, di una epistemologia, e che, in
particolare, essa ha spinto, forse più lontano di quanto non fosse
stato mai fatto, non soltanto in India, ma, pare, in qualsiasi altra
parte del mondo, la pratica della esegesi sistematica. Essa ne ha
fissato parecchi punti, come, ad esempio, il ruolo che ha la
posizione di una parola nella frase, ha elaborato una teoria del
contesto, che permette di dare ad enunciati formalmente identici
significati diversi in funzione della differenza dei concetti e
inversamente, eccetera. Quindi ha fornito uno strumento dialettico e
concettuale notevole ai suoi stessi avversari, ma parallelamente ha
funzionato come ideologia capace di fondare la preminenza della
casta bràhmanica, poichè presenta elementi che si collegano tutti
tra di loro: l'autorità del Veda con il carattere "apauruseya", cioè
l'origine non umana del Veda, e col primato della casta bràhmanica,
come depositaria privilegiata del sapere vedico, tanto sul piano del
rituale, quanto su quello della conoscenza. Questo, mi sembra, può
bastare per una prima caratterizzazione della mìmàmsà.
DOMANDA: E il
vedanta?
Il vedanta è la "seconda mìmàmsà". Qual è inizialmente il suo
rapporto con la "prima mìmàmsà"? Bisogna dire che la "prima mìmàmsà"
presa per sé sembra bastare a se stessa e non si oltrepassa verso
uno sviluppo ulteriore. Ma bisogna anche segnalare a questo
proposito che in fondo la "prima mìmàmsà" resta chiusa a tutto un
versante del pensiero religioso, del pensiero vedico anteriore, nel
senso che riduce tutto ai sacrifici, al rituale, alla meccanica che
porta dall'atto sacrificale alla retribuzione del sacrificio. Ma è
del tutto chiaro sia per noi sia per gli Indiani che il corpus
vedico non si esaurisce, non è riducibile a una serie di
prescrizioni e di interdizioni o di commenti al sacrificio.
In particolare in un segmento del corpus vedico, quello costituito
dalle celebri Upanishad, incontriamo degli enunciati, che sono
fondamentalmente refrattari alla classificazione operata dalla
"prima mìmàmsà". Sono gli enunciati cui possiamo provvisoriamente
apporre l'etichetta di "mistici", cioè tutti quegli enunciati che
riposano in un modo o in un altro su una identificazione o su una
possibilità di identificazione tra la persona umana e il cosmo.
Beninteso l'archetipo di quelle formule vediche, che vanno al di là
della logica del sacrificio, è fornito da quelle che si chiameranno
piu' tardi le "grandi parole" o "mahavakya", come il celebre "tat
tvam asi", "tu sei questo". "Anche tu sei questo", dice il bràhmano
Udalaka Aruni a suo figlio Svetaketu, tu nella tua realtà
psicologica attuale sei, senza saperlo, identico al principio
ultimo, all'origine dei fenomeni, che è il "bràhman", termine che
d'altronde la mìmàmsà conosce, ma non conosce che sotto la forma di
ciò che fonda in ultima istanza l'efficacia del sacrificio. Dunque
questa possibilità di creare corto circuito col sacrificio, questa
possibilità di entrare in relazione diretta e al limite in una
relazione di identificazione con il "bràhman", senza passare per il
sacrificio, questa possibilità è ignorata, trascurata o negata dalla
mìmàmsà, ed è stata vocazione della "seconda mìmàmsà" farsene
carico. D'altronde il nome stesso di vedanta dice già questo:
vedanta significa "veda anta", fine del Veda o cambiamento del Veda.
Spendiamo qualche parola sulla genesi del vedanta. Questa genesi si
determina a partire da quello che si chiama "prastana traya"
"tripode", triplice punto di partenza, dei quali l'uno è fornito
dalle stesse Upanishad, il secondo dalla Bhagavad Gìtà, che sarà
interpretata in questa prospettiva, forse non senza una certa
forzatura del testo, e il terzo da una prima raccolta di sùtra, che
si chiama "Brahmasutra", aforismi mnemonici sul "bràhman",
attribuiti a un certo Badarayana, che sarebbe vissuto intorno al I
secolo della nostra era e di cui non sappiamo molto. Non ho parlato
poco fa dei sùtra della mìmàmsà di Jaimini, loro autore presunto, la
cui situazione è per qualche verso simile, ma ciò in fondo ha
un'importanza secondaria. Ciò che si è prodotto nei primi secoli
della nostra era, è l'inizio di una letteratura di commenti
imperniati sulle Upanishad, sulla Bhagavad Gìtà, sui sùtra, ma -
fenomeno che ritorna a più riprese nell'India antica - quei primi
commentatori bràhmanici oggi non sono più per noi che dei nomi,
perchè più tardi, esattamente verso la metà dell'VIII secolo d.C., è
sopraggiunto un commentatore le cui qualità eccezionali, la cui
penetrazione e sistematicità hanno contribuito a eclissare
totalmente gli altri, al punto che i loro commenti non erano più
ricopiati nei manoscritti.
Praticamente per noi il vedanta, nella sua forma classica, nella sua
forma di sistema filosofico a pieno titolo, riceve il maggiore
impulso dalla personalità di questo commentatore fuori del comune,
cioè l'illustre Çamkara, di cui non conosciamo le date esatte, ma
che è vissuto ed è fiorito non si sa bene dove intorno alla metà
dell'VIII secolo. Si potrebbe aggiungere pure il suo predecessore
Gaudapada, autore di stanze in versi su una Upanishad, ma
l'essenziale della dottrina risale a Çamkara. Qual è la forma che
Çamkara ha dato inizialmente al vedanta? Dapprima due parole sulla
sua opera, commento dei "Brahmasutra" da una parte, della Bhagavad
Gìtà dall'altra e infine delle Upanishad vediche maggiori. Il punto
di partenza di Çamkara è precisamente in quelle "grandi parole" che
la mìmàmsà non era in grado di integrare in modo significativo: il
"tat tvam asi". Allora è evidente che il suo problema filosofico è
già segnato da questo punto di arrivo - problema filosofico che
consiste nel mostrare, nel far comprendere la possibilità stessa di
una tale identificazione. Abbiamo le due estremità di una catena,
assai lontane l'una dall'altra, che devono ricongiungersi. Da un
lato, sulla base dell'autorità incondizionata del Veda, dobbiamo
porre l'identità assoluta dell'anima individuale o dell'àtman col
"bràhman", dall'altra partiamo dalla nostra esperienza umana, del
tutto limitata, condizionata, nella quale niente ci permette di dare
un significato intuitivo a quella identità, e si può dire che tanto
sul piano della speculazione dottrinale, quanto sul piano delle
pratiche spirituali che promuove, Çamkara si assegna come compito di
rendere possibile la riduzione e al limite l'abolizione di quello
scarto. Dunque sul piano speculativo incontriamo una teoria che mira
a spiegare perché l'unità assoluta di tutte le cose nel "bràhman",
che è di diritto, non è immediatamente avvertita come tale da noi
nella percezione, dove abbiamo a che fare con un mondo
apparentemente multiforme, sicché il principio spirituale, il
"bràhman" sembra disperso in una quantità, in una miriade infinita
di esseri umani, di animali, eccetera. Che cosa può spiegare questa
dispersione del "bràhman"? Si fa intervenire qui la teoria della
maya o dell'illusione cosmica, detta anche dell' "avidya" o del
misconoscimento della propria natura, in cui ogni anima individuale
incorre. Non possiamo entrare qui nei particolari, che sono forniti
meno da Çamkara stesso che dalla sua scuola, dai numerosi
successori, che perfezioneranno il suo sistema nelle età successive.
Ciò che si può dire è che egli elabora già una dialettica con cui
tenta di mostrare che l'esistenza nella sua pluralità è un fatto di
cui non si può rendere conto logicamente e che quando esaminiamo la
possibilità di ricostruire l'esperienza che ci fornisce la
percezione sensibile, incontriamo ogni genere di contraddizioni, che
sono come altrettanti segni della necessità di cercare oltre.
Muovendo di qui Çamkara tenta di tracciare tutto un itinerario di
pratiche, di meditazioni delle "grandi parole" vediche, che mirano a
epurarle del loro significato iniziale. In altri termini si riparte
dal "tat tvam asi", dal "tu sei questo", termini che sembrano
incompatibili. Ma la meditazione si orienta nelle due direzioni al
tempo stesso: quella del "tat", del "questo" e quella del "tvam" del
"tu". Da una parte, poiché si tratta del "tat" cioè del "questo", si
mostra che il "bràhman" non è quella specie di entità trascendente,
misteriosa, lontana, che sembra essere ad un primo approccio, ma che
c'è una specie di immanenza, di presenza del "bràhman" fin dentro le
nostre funzioni mentali. Per esempio Çamkara elabora, sette o otto
secoli prima di Descartes, un procedimento riflessivo sulla presenza
del "bràhman" in noi, che anticipa largamente il "cogito".
L'affermazione assoluta della persona, anteriore allo spiegamento
dei mezzi della retta conoscenza, questa affermazione è intesa da
Çamkara come il segno della presenza del "bràhman" in noi e quindi,
parallelamente, il "tvam", il "tu" diventa a poco a poco oggetto di
un'analisi che lo spoglierà di tutte quelle che Çamkara chiama le
"upadhi", cioè le determinazioni avventizie, contingenti, che lo
rivestono e che in quanto tali sembrano allontanarlo dal "bràhman".
Dunque il "bràhman" interiorizzato da una parte, il soggetto
individuale, spogliato delle sue particolarità dall'altra, si
presentano come essenze, la cui fusione in una sola e stessa entità,
appare sempre meno inverosimile. Beninteso non è questione di mera
speculazione filosofica. C'è tutta una pratica spirituale di cui
Çamkara ha tracciato i lineamenti essenziali che si chiamano
"nididiasana" eccetera, diverse maniere infine di interiorizzare le
parole vediche, fino a che ne scaturisca intuitivamente, ad un certo
punto, la realizzazione della verità del "tat tvam asi",
conformemente d'altronde a presupposti che debordano largamente i
darçana, che sono validi anche per il buddhismo e per quasi tutto il
pensiero religioso indiano. Questa presa di coscienza dell'identità
dell'anima individuale e del principio che sottende i fenomeni
esterni ha il valore di una conoscenza, una sfera di gnosi, che non
permette più di interessarsi passionalmente agli eventi mondani, di
sentirsene investiti. Di conseguenza si esaurisce la fonte del
karman, di quella famosa ripercussione dei nostri atti e dei nostri
pensieri su noi stessi e sulle nostre esistenze individuali. E
all'individuo che è passato per questa conoscenza non resta che
liquidare in qualche modo le conseguenze del suo "karman" anteriore,
per conseguire quella che sarà chiamata "liberazione", cioè una
misteriosa fusione col "bràhman", a proposito della quale,
d'altronde, Çamkara resta nel vago, perché si ha qui a che fare con
un concetto-limite, che la riflessione filosofica può in qualche
modo preparare, giustificare, ma non dedurre integralmente.

DOMANDA: Si può adesso passare alla seconda
coppia composta dal Sàmkhya e dallo yoga. Ci può parlare
innanzi tutto del Sàmkhya?
Il termine Sàmkhya può essere tradotto con
"enumerazione". Enumerazione sistematica di tutti i principi
costitutivi del reale. Bisogna dire che il Sàmkhya è un sistema
filosofico classico, un darçana che è stato anticipato fin nei
particolari dalla speculazione protofilosofica anteriore. Certe
Upanishad, il Mahàbhàrata, la Bhagavad Gìtà, d'altronde, contengono
anch'esse molti elementi del Sàmkhya. Nondimeno il Sàmkhya classico
prende forma, con una raccolta di stanze, "karika", attribuite ad un
certo Isvarakrisna, che datano dal IV secolo d.C. Il fondamento del
sistema Sàmkhya è questo: il Sàmkhya si presenta innanzi tutto come
un dualismo, cioè oppone due principi metafisici irriducibili l'uno
all'altro: l'uno chiamato "prakriti", con un termine che vuol dire
letteralmente "procreatrice" e che abbiamo preso l'abitudine di
rendere, nelle lingue europee, con "natura", "natura creatrice", a
volte "natura naturans"; l'altro chiamato "purusa", termine che
letteralmente vuol dire "uomo", che designa un principio spirituale,
presente nell'uomo, ma anche negli altri esseri viventi e che si
traduce, bene o male, ora con "Spirito" (con la maiuscola) ora con
"monade spirituale" - ma in realtà non abbiamo un termine adeguato
per caratterizzare questo "purusa", perché è appunto qualcosa che
non ha un equivalente nel pensiero filosofico europeo. Allora che
cos'è la "prakriti"? Ebbene la "prakriti" è intesa come una specie
di sostanza materiale universale, la stoffa di cui sono fatti e da
cui si staccano, con una sorta di sconnessione, non soltanto le
realtà sostanziali che costituiscono il mondo materiale esterno, ma
anche tutto ciò che, per esempio, costituisce la nostra realtà
empirica di esseri viventi, così com'è osservabile dall'esterno:
quindi non soltanto il nostro corpo visibile, esterno, ma
altrettanto i nostri sensi, e tutto ciò che ci costituisce come
soggetti viventi, attivi, che entrano in rapporto col mondo, che
percepiscono, memorizzano, riflettono, eccetera. Io credo che non si
insisterà mai troppo su questo punto. Se non fosse d'altro lato per
la presenza del "purusa", il Sàmkhya potrebbe passare per una specie
di materialismo, nel senso che mette sul conto della natura, della
produttività della natura, l'insieme dei fenomeni non soltanto
cosmici esterni, ma anche psicologici. In altri termini, nel momento
stesso in cui parlo e in cui tento di dare, bene o male, una certa
coerenza, un significato alle mie proposizioni, il Sàmkhya analizza
ciò che sta accadendo in me come un insieme di fenomeni, di
spostamenti di forze e di cariche in seno alla materia sottile di
cui sono internamente composto. Il segno di ciò appare anche in
un'altra dottrina abbastanza tipica del sistema Sàmkhya, che è la
dottrina dei "guna", cioè delle qualità o degli attributi del reale.
Il Sàmkhya afferma che tutto ciò che appare nell'esperienza, appare
sempre il risultato di una combinazione o di un'altra, dei tre
attributi fondamentali che esso distingue e che sono - dico prima i
termini in sanscrito - il "sattva", il "rajas", il tamas. E'
caratteristico che ognuno di questi attributi costitutivi del reale,
di questi modi, attribuibili a qualsivoglia sostanza individuale,
comportano tutta una gamma di significati, una specie di ricchezza
semantica, che va per noi dai significati pertinenti soltanto alla
sfera materiale, fino ai significati psicologici o quasi-spirituali.
Se prendiamo in considerazione il "sattva", si tratta di un
principio che nell'ordine della materia connota la luminosità, per
esempio la luminosità di una lampada, la luminosità di un cielo
chiaro, ma connota anche la leggerezza, il fatto, per esempio, che
il fumo si innalza nel cielo, eccetera; ma lo stesso "sattva", su
altri registri, connoterà degli stati di euforia fisiologica, come
quando ci sentiamo leggeri e niente ci pesa; e a un livello più alto
ancora, il "sattva" connoterà una sorta di gioia interiore, una
luminosità della persona, una "bontà" (tra virgolette), degli atti
che possiamo compiere. Non bisogna vedere una contraddizione in ciò,
perchè il Sàmkhya, per quanto sembri un dualismo, non lo è affatto
nel senso cartesiano del termine, e la sua "materia prima"è
portatrice, attraverso gli attributi, di un complesso di valori che
si dispongono su tutti questi registri. Quindi si potrebbe dire
altrettanto dell'antitesi del "sattva", che è il tamas,
letteralmente l'"oscurità" e le "tenebre". Si va dalla pesantezza
della pietra che poggia sul suolo, fino all'inerzia mentale, alla
stupidità e all'ebetudine di colui che, per un motivo o per un
altro, è lento o contraddittorio o confuso nel suo pensiero. E
infine c'è il "rajas". E' un principio intermedio tra il "sattva" e
il tamas, che ne riflette appunto l'opposizione essenziale. Il
"rajas" è un principio di instabilità, di tensione e perciò stesso
di sofferenza. La parola "sofferenza" ci permette di arrivare
nell'altro principio, del Sàmkhya e al tempo stesso alla
congiunzione dei due principi. Dunque abbiamo parlato fin qui della
"prakriti", della natura e del suo sviluppo, secondo quelli che il
Sàmkhya chiama i "tattva", principi costitutivi del reale. Ci resta
da parlare del suo antagonista, il "purusa", il principio
spirituale. Dato che tutto l'elemento concreto, dinamico,
significativo, nell'attività degli esseri viventi e non viventi, è
dal lato della "prakrti", ne consegue che il Sàmkhya è
necessariamente portato a considerare il "purusa" come un essere
perfettamente estraneo ad ogni azione e ad ogni passione. In realtà
il Sàmkhya si rappresenta il "purusa" come una specie di specchio,
come una coscienza-testimone, come si dirà piu' tardi. Il "purusa" è
spettatore del dispiegarsi della natura al suo cospetto. D'altronde
la metafora dello spettatore e della danzatrice, che si produce
sulla scena, è usata proprio nelle "Samkhyakarika". Se non ci fosse
il "purusa", non si produrrebbe nulla, cioè dal punto di vista del
Sàmkhya quella danza della natura, quel dispiegamento da parte della
natura di ciò che è in lei racchiuso, dei principi costitutivi del
reale, non si produrrebbe. Non si produce che nella misura in cui
natura e spirito entrano in congiunzione l'una con l'altro e il
modello, il filo conduttore per studiare quella congiunzione è
naturalmente ciò che noi chiamiamo l'unione dell'anima e del corpo.
Si potrebbe anche dire in un altro senso che il Sàmkhya è una
filosofia integrale che si costituisce riflettendo sul mistero
dell'unione dell'anima e del corpo. Dunque l'analisi che fa il
Sàmkhya è grosso modo questa: la congiunzione di due entità (quale
che sia la sua causa prossima) ha sempre la sua origine in quella
famosa ignoranza metafisica, in quel misconoscimento di sé, di cui
ho parlato prima, riguardo al vedanta e che si ritrova, "mutatis
mutandis", nel Sàmkhya. Dunque una volta ammesso quell'irrazionale,
quel presupposto, il Sàmkhya analizza la condizione umana, la
condizione dell'essere finito in generale, come il turbamento
prodotto dall'unione di due principi metafisici, che sono
radicalmente distinti l'uno dall'altro. Da una parte la "prakriti",
dispiegandosi, procura, per così dire, al "purusa" strumenti per
esperire il mondo, come i sensi eccetera, d'altra parte il "purusa"
dimentica la sua essenza, dimentica di essere una "monade
spirituale", chiusa in sé, autosufficiente, autoilluminantesi, come
dirà piu' tardi anche il vedanta, crede che qualcosa gli manchi, si
mostra come un essere di desiderio, come un essere volto verso il
mondo, in breve si identifica con i modi della materia a cui si
trova unito. Per riassumere in modo schematico, si identifica con
l'organismo fisiologico e in particolare con quelle entità
materiali, lo ripeto, ma certamente sottili e quasi indiscernibili,
che il Sàmkhya chiama "manas", senso comune, e "buddhi", intelletto.
In altri termini il "purusa" si trasforma in agente, in autore di
atti, e si trasforma altrettanto in soggetto dell'esperienza
affettiva. Diventa attivo, spera, crede, compie delle imprese nel
mondo e subisce su di sé le conseguenze degli eventi del mondo. Il
Sàmkhya riassume questa analisi dicendo che la nostra è
essenzialmente un'esperienza del turbamento, della predominanza del
"rajas", dunque della sofferenza. Perciò si può supporre che abbia
subito all'origine un'influenza buddhista. Detto questo, è tracciata
la via. Una volta fatta la diagnosi che tutta la nostra infelicità,
la trasmigrazione, è causata dal fatto che entriamo in confusione
con ciò che non siamo, il metodo del Sàmkhya consisterà in una
riflessione che permetta al "purusa" di riprendere coscienza di ciò
che è, della sua natura fondamentale e l'esperienza cruciale per lui
è la "viveka", cioè la discriminazione da lui operata. In altri
termini la sua relazione con la natura finisce con un ultimo
percorso mentale, un ultimo esercizio delle sue funzioni mentali, al
termine del quale quella relazione viene resa impossibile. Il
"purusa" recupera la sua autonomia essenziale e la dottrina chiamerà
questo stata "kaivalya", isolamento spirituale. Il "purusa" resta
per sempre ripiegato su di sé, chiuso in sé. Ci sono qui delle
evidenti analogie con il percorso del vedanta, benché nel Sàmkhya
l'osservanza del Veda sia assai meno netta. Una differenza
importante che si può notare di passaggio quando si descrive il
"purusa" liberato, in opposizione all' àtman liberato del vedanta, è
che mentre per il vedanta l' àtman è fondamentalmente uno e la sua
percezione di sé, come di uno tra molti, come di uno spirito
individuale, tra una moltitudine di spiriti simili, fa parte
anch'essa dell'illusione, per il Sàmkhya al contrario la dispersione
dei "purusa", l'infinita molteplicità dei "purusa" è una realtà
metafisica insormontabile. In altri termini c'è una sola natura, una
sola "prakriti" e poi una infinità di "purusa" che, abitualmente,
entrano in contatto con essa, si confondono con essa, ma di cui,
almeno alcuni, riescono a trovare in qualche modo un varco, l'uscita
fuori del "samsara", fuori della trasmigrazione, svincolandosi dalla
natura. Dunque anche nella liberazione i "purusa" resteranno
ciascuno per sé e evidentemente ciò che può fare difficoltà in
questo sistema è che non si sa più bene che cosa ne è della loro
distinzione reciproca, dato che la loro essenza è assolutamente
comune. Questo è quello che si può dire.
DOMANDA: Professor
Hulin, che cos'è lo "yoga"?
Vedrei lo "yoga" come un sistema gemello del "samkhya" o come
complementare. E' certo in ogni caso che parecchie nozioni cardinali
in cui si articola il "samkhya", sono ammesse anche dallo "yoga": il
purusa, la prakriti, i guna, eccetera. Si può dire che in un certo
modo la metafisica del "samkhya" è alla base di quella dello "yoga".
Allora perché un altro sistema? Probabilmente perchè il "samkhya" è
restato sempre una operazione essenzialmente intellettualistica e
teorica e forse non era in possesso dei mezzi necessari per guidare
i suoi adepti verso il fine che indicava loro, cioè la disgiunzione
del "purusa" dalla natura e il conseguimento dello stato di
isolamento spirituale o "kaivalya".
Questo avviene perché il "samkhya" fondava tutto sulla conoscenza
della dottrina, l'enumerazione dei principi, la realizzazione
soltanto intellettuale, visto che per sua stessa essenza il "purusa"
non poteva avere niente in comune con la natura. Evidentemente c'è
una distanza notevole tra l'assimilazione intellettuale di una
dogmatica di quel genere e l'applicazione del principio della
disgiunzione nel concreto, nella serietà e nello spessore
dell'esistenza. Ogni sorta di ostacoli si oppongono a una tale presa
di coscienza.
Si può dire che lo "yoga", o almeno il sistema classico dello
"yoga", come ci è trasmesso dai "sutra" di Patanjali, risponde a
questo bisogno, che il "samkhya" non poteva soddisfare.
Un segno evidente ne è la modificazione - o piuttosto
l'arricchimento - che lo "yoga" apporta alla teoria delle funzioni
mentali e delle attività psichiche elaborata dal "samkhya". In altre
parole, a fianco a quelle riconosciute dal "samkhya", come il
"manas", la funzione dell'io, l'intelletto, eccetera, lo "yoga" fa
posto alla citta, termine che si traduce generalmente, più o meno
bene, con attività psichica
Forse quest'espressione non vuol dire molto, ma la sua funzione si
chiarirà dicendo che la "citta" serve essenzialmente allo "yoga" per
integrare un aspetto dell'esperienza, che il "samkhya" certo non
ignorava, ma al quale non riservava una trattazione particolare.
Penso a quell'aspetto dell'esperienza per cui, secondo le dottrine
indiane, tutto ciò che noi produciamo in fatto di pensieri,
progetti, fantasie e naturalmente i nostri atti stessi, ci
modificano a loro volta per una specie di contraccolpo. In altri
termini ci troviamo davanti al postulato indiano per cui non si
pensa e non si agisce mai impunemente, ma si resta marcati,
durevolmente impregnati dai significati e dalle intenzioni che
abbiamo riposto nelle nostre azioni.
L'assunzione del "citta" da parte dello "yoga" corrisponde appunto
alla preoccupazione di trovare qualcosa in cui scrivere l'impatto
dell'esperienza, l'impatto degli atti e soprattutto qualcosa in cui
iscrivere la dinamica ulteriore degli atti. Bisognerebbe introdurre
qui alcune nozioni classiche dello "yoga" e di altri sistemi del
brahmanesimo, che si chiamano "samskara" e "vasana", cioè le tracce
residue, le formazioni residue, lasciate dagli atti anteriori,
comprese non tanto come tracce, come residui passivi, ma soprattutto
come residui, come tracce attive, propensioni e abitudini, appena
abbozzate, pieghe prese, per così dire, dalla psiche, che contengono
la promessa di azioni future, che andranno nello stesso senso e che
lo "yoga" sistematizzerà sotto il nome di "klesa".
Ciò vuol dire che, non contentandosi della nozione troppo generale
di ignoranza di sé, di "avidya" o ignoranza metafisica, come il
"samkhya" classico, lo "yoga" precisa, arricchisce la nozione di
"avidya", mostrando le sue specificazioni sotto forma di
attaccamenti, di attaccamenti passionali, che portiamo con noi
attraverso l'esperienza, e attraverso le nostre esistenze
successive. Tendenze, passioni, "afflizioni", come vengono anche
chiamate, hanno la funzione di attaccarci con sempre maggior forza
alla "prakriti".
Quindi lo "yoga" pensa che non è possibile accontentarsi di
distinzioni meramente intellettuali, che il luogo, il livello in cui
i "samskara" sono iscritti è tale che le semplici distinzioni
intellettuali non possono coglierli. Siamo cioè in una situazione in
cui, mentre vediamo il meglio, siamo necessitati a scegliere il
peggio. Lo "yoga", individuando la nozione di "citta", si propone di
intervenire al livello che gli è proprio, in modo che la verità
essenziale che condivide con il "samkhya" e cioè il principio della
discriminazione tra "purusa" e "prakriti", come chiave della
liberazione, che, secondo lo "yoga", restava nel "samkhya" un
programma meramente teorico, diventa adesso raggiungibile in questa
vita. Ne deriva la definizione che dà di se stesso fin dall'inizio
degli aforismi di Patanjali: "yogacittavrttinirodha".
Che cos'è lo "yoga"? E' la fine, è l'arresto delle "vrtti", cioè dei
movimenti incontrollati, emozionali, passionali del "citta", cioè
dell'attività psichica. In un certo senso lo "yoga" è uno sforzo per
immobilizzare, per neutralizzare l'attività psichica, perché in essa
vede la radice di ogni resistenza, delle più profonde resistenze
inconsce, all'attuazione, alla messa in opera delle verità
metafisiche, mantenute dal "samkhya" su un piano puramente
intellettuale.
DOMANDA: Quali
sono le conseguenze pratiche della via yogica?
Si è ricondotti al programma proposto da Patanjali. Si tratta di un
itinerario spirituale composto di otto "anga" o "tappe". Ciò che il
"samkhya" in principio considera da lontano mediante la semplice
discriminazione, sarà conseguito nella prospettiva yoghica
progressivamente, con un avvicinamento graduale, attraverso un
percorso, segnato in anticipo, che è quello degli otto "membri" o
"tappe" dello "yoga". Possiamo passare rapidamente in rassegna
queste "tappe".
Le prime due che si chiamano yama e niyama sono in qualche modo
preparatorie alla via propriamente detta, sono cioè delle
costrizioni, delle discipline, le une più di carattere sociale, le
altre riguardanti l'individuo, che comportano un minimo di controllo
di sé, un minimo di disciplina, un minimo di purezza, condizioni
necessarie, benché evidentemente non sufficienti per qualificarsi a
percorrere la via yogihca. Lo "yoga" propriamente detto comincia con
la terza "tappa", ben nota in Occidente, degli asana o "posture",
posture particolari alle quali il corpo deve essere piegato.
Devo dire a questo proposito che nello "yoga" classico di Patanjali,
il solo di cui parleremo, e che è l'autentico complemento del
"samkhya", gli "asana" o "posture", pur essendo indispensabili, non
hanno lo stesso ruolo che in altre forme ulteriori di "yoga", come
quella che si chiama "hathayoga". Patanjali si limita a raccomandare
un certo numero di "posture" semplici, "posture" di meditazione
diverse dalle posture acrobatiche, miranti a sucitare energie nel
corpo e che aprono una via diversa da quella di cui ci occupiamo
qui.
Bisogna dunque cominciare dall'inizio, bisogna cominciare con
l'individuare l'agitazione della "vritti", sorprenderla nelle sue
espressioni piu' grossolane, più immediatamente controllabili, le
varie contratture in cui si irrigidisce il corpo all'insaputa
dell'individuo, e che in quanto tali già esprimono quei famosi
"klesa" o "afflizioni", che costituiscono l'ostacolo piu' arduo.
La terza tappa è dunque quella degli "asana". Viene in seguito
qualcosa che è abbastanza noto, sotto il nome di pranayama, cioè il
controllo del respiro, il prolungamento della ritenzione del
respiro, sia nella fase espiratoria che in quella inspiratoria, il
prolungamento del ciclo respiratorio nel suo complesso. Aanche
questi esercizi non hanno il loro scopo in se stessi. Il loro scopo
non si esaurisce affatto nel loro effetto fisiologico, innegabile,
ma è al tempo stesso simbolico.
E' stato osservato che lo "yoga" capitalizza, in queste tecniche,
secoli di osservazioni compiute dagli asceti dell'India antica,
secondo le quali il turbamento interiore si traduce non soltanto
nelle contratture del corpo a cui accennavo prima, ma anche nel
carattere relativamente rapido e soprattutto superficiale della
respirazione. D'altro canto si è compreso assai presto che
l'amplificazione del ritmo respiratorio, la sua regolarizzazione
aveva un'influenza positiva sul corso dei pensieri, e che il caos
mentale ha qualche opportunità di diminuire, dal momento che certe
sue espressioni somatiche vengono sospese. Al di là del "pranayama",
che costituisce la quarta tappa, si trovano tecniche più
specificamente yoghiche, tali che è difficile affrontarle senza un
istruttore qualificato, sicché la loro diffusione in Occidente è
assai più difficile che per le altre già citate.
Troviamo in primo luogo il pratyahara, cioè il metodo che consiste
nell'allenare i sensi al distacco sistematico dagli oggetti, per
fare ritorno in qualche modo sul soggetto. Si tratta di un complesso
di pratiche, miranti a permettere al soggetto di "togliere la
corrente", come si dice volgarmente, per non essere "bombardato"
dalla massa incontrollata dei messaggi, che in circostanze ordinarie
gli arrivano continuamente dal mondo sensibile. Si può procedere
selezionando questo o quel senso, la vista, l'udito, il tatto,
eccetera. Si possono alternare i sensi su cui questo esercizio viene
praticato, ma in ogni caso si tratta veramente di uno sforzo per
sostituire, in definitiva, all'osservazione esteriore o
estrovertita, un'osservazione e un'attenzione rivolta verso
l'interno, verso ciò che avviene nel soggetto, verso i suoi ritmi
biologici e fisiologici. Per esempio è evidente che il passaggio
dalla regolazione del respiro al "pratyahara" non è affatto
arbitrario. L'attenzione diretta sul meccanismo del respiro si
presenta in un certo modo come qualcosa che può sostituire, almeno
per un po', la percezione volta all'esterno.
Da questo momento si può avanzare verso i tre ultimi stadi dello
"yoga" classico, che prendono anche una denominazione comune
generica, che non è il caso di riferire qui. Questi stadi sono
dunque: il sesto che si chiama dharana, sforzo di fissare
l'attenzione su un oggetto qualsiasi. Qui si dà un'infinita gamma di
possibilità. Può essere un oggetto fisico qualunque, una foglia per
esempio o la fiamma di una candela, o un'immagine divina che si
contempla nella sua totalità o di cui si sceglie, mediante
l'attenzione, questo o quell'attributo. Si tratta quindi di
focalizzare l'attenzione sempre sullo stesso oggetto, allo scopo di
evitare la dispersione della concentrazione percettiva e soprattutto
la dispersione mentale, legata alla varietà degli oggetti, sui quali
possiamo lasciare errare il nostro sguardo e che hanno tutti per noi
un significato affettivo. Dunque "dharana" è uno sforzo per fissare
certi contenuti sensibili, che poi in determinate circostanze
potranno divenire più astratti, attraverso la simbolizzazione. Per
esempio la famosa sillaba "om" che in un certo senso potrebbe
riassumere i dogmi fondamentali dell'induismo, può costituire certo
un oggetto privilegiato di concentrazione.
Il famoso "mantra", "So Ham", "io sono quello" eccetera, può essere
usato anch'esso in questa prospettiva. Delle due ultime tappe di cui
è difficile parlare, perché sono veramente esoteriche, perché il
linguaggio comunque troppo legato alla percezione sensibile esterna,
non è adatto a renderle, l'una va sotto il nome di dhyana,
"meditazione continua". A un dato momento bisogna trattenere un
contenuto sul quale prima si è fissata l'attenzione, senza essere
piu' asserviti a un uso, sia pur minimo, dei sensi, che era la
regola nello stadio precedente.
Si tratta sempre di concentrazione, ma di una concentrazione
puramente interiore, una concentrazione mentale, "dhyana", che
generalmente è tradotta con "meditazione continua". Si tiene fermo a
un oggetto. Naturalmente si tratterà piuttosto di un oggetto
astratto. Eventualmente i punti fondamentali della pratica
intellettuale del "samkhya" potranno essere usati per ottenere
questo effetto: si potrà avere una specie di concentrazione, per
esempio, sulla distinzione essenziale del "purusa" e della
"prakitri" o su altre nozioni di questo genere.
Si suppone che il "dhyana" si completi in un'ultima tappa, di tutte
la più enigmatica, divisa a sua volta da Patanjali e dai suoi
commentatori, in parecchi stadi - ma non potrò entrare nei
particolari, - che si chiama samadhi, termine estremamente difficile
da comprendere, ma di cui si può dire ad ogni modo che rappresenta
la realizzazione del programma annunciato nel secondo "sutra" di
Patanjali, "yogacittavittinirodha", ovvero "arresto delle
fluttuazioni dell'attività psichica". In altri termini il "samadhi"
è la messa in quiescenza delle funzioni psichiche, si potrebbe quasi
dire la messa fuori circuito dell'attività psichica.
La vita psichica è paragonata a un oceano, senza più movimento
ondoso, la cui superficie è assolutamente liscia. Giunti a questo
punto si pensa che fra "purusa" e "prakriti" non succeda più nulla.
Si potrebbe anche chiamare il "samadhi", proprio in conseguenza
della messa fuori circuito dell'attività psichica, per cui il
"purusa" arriva a coincidere con se stesso, come il ricongiungimento
del "purusa" con sé.
Questo risultato non è affatto differente da quello del "samkhya",
ma il metodo per conseguirlo è assai più lungo. Il "samkhya" ci
propone un'ascensione abrupta, estremamente difficile, e che forse
mai nessuno o pochi hanno potuto realizzare. Lo "yoga" propone di
arrivare allo stesso culmine, ma aggirando la montagna
dell'ignoranza, con una strada a tornanti, assai lunga e a suo modo
difficile, ma non di meno più agevole dell'altra. Certo ci sono
altre differenze significative, ma che si possono tralasciare qui,
tranne una. Mentre il "samkhya" è radicalmente ateo, non riconosce
che i "purusa" e la natura di fronte a loro, il sistema dello "yoga"
classico ammette un "Isvara", un "Signore", ma lo considera in
definitiva come un ideale, che lo "yoghin" propone a se stesso e che
cerca di raggiungere. Questo Signore non è inteso come un creatore
dell'universo, nel senso teista del termine, ma come uno "yoghin"
prototipico, di "yoghin" ideale, libero in eterno, perché non ha mai
conosciuto la confusione con la "prakiti". Perciò costituisce il
modello cui lo "yoghin" tenta di adeguarsi, realizzandolo in sé.

DOMANDA: Ci resta da esaminare la terza
coppia: nyaya e vaisesika.
"Nyaya" e "vaisesika" è la coppia forse più vicina a certi sviluppi
della filosofia occidentale, sia greca che moderna, ma anche quella
meno seducente ai nostri occhi di Europei. Almeno tre dei sistemi di
cui abbiamo parlato sin qui, il "vedanta", il "samkhya" e lo "yoga",
si presentano essenzialmente come soteriologie, dottrine nelle quali
le pratiche intellettuali non hanno altro scopo che di sormontare la
sofferenza e interrompere la trasmigrazione.
Al contrario questa preoccupazione soteriologica, senza essere del
tutto assente, è tuttavia alquanto esteriore e tardiva negli ultimi
"darsana" di cui parleremo: il "nyaya" e il "vaisesika".
Tratteggiamo concisamente entrambi.
Il "nyaya" etimologicamente è l'arte di dirigere il proprio
pensiero, Il "nyaya" è quindi innanzi tutto una logica, che assai
presto nel corso del tempo si è ampliata in una epistemologia e
anche in una psicologia. L'essenziale delle ricerche del "nyaya"
verte sulla teoria della dimostrazione. Il "nyaya" da una parte si
colloca nel classico quadro dei "pramana", dei mezzi della retta
conoscenza, di cui abbiamo già parlato a proposito della "mimamsa".
Quindi ha elaborato una teoria della percezione, ma in questo campo
non è affatto originale: ha messo soprattutto l'accento sul
procedimento chiamato "anumana" e che si traduce con "inferenza" o
ragionamento inferenziale.
Il "nyaya" si è sforzato di codificare, di formalizzare l'"anumana".
Di che si tratta? Si può dire che per quasi tutti i "darsana"
classici, per quasi tutte le teorie classiche della conoscenza,
nell'India brahmanica, in materia profana, cioè quando si tratta
della conoscenza del mondo sensibile, la percezione costituisce
veramente la base, il fondamento, e tutti riconoscono il primato
della percezione. Nondimeno bisogna riconoscere che la percezione ci
vincola al presente. La percezione non conduce a ciò che esisteva
prima di noi e a ciò che esisterà dopo di noi e l' "anumana" in
fondo è intesa come una specie di estensione sistematica della
percezione, a sfere di esperienza sulle quali la percezione diretta
non ha presa.
L'esempio classico sul quale il "nyaya" ha ricamato lungamente nel
corso dei secoli e che ha sempre più affinato è il famoso esempio
del fumo e del fuoco. Si dimostra che una montagna o una collina può
essere o è attualmente preda di un incendio, perché da quella
montagna o da quella collina vediamo alzarsi del fumo.
Su questa base il "nyaya" edifica una struttura logica in cui mira a
formalizzare gli elementi del ragionamento. Il "nyana" definisce la
cosa da provare, la proprietà da provare, la cosa di cui si vuole
provare qualcosa e la ragione che è il motore della prova e che è
chiamata "hetu", e si addentra in problemi assai delicati di
implicazione tra ciò che è da provare e ciò che serve da prova.
Per esempio il motore della prova è nel fatto che ogni volta che c'è
fumo deve esserci anche fuoco o in altri termini che l'elemento del
fumo è in un certo senso compreso sempre nell'elemento del fuoco.
Quindi siamo di fronte a un movimento a cinque tempi, che è stato
spesso paragonato al sillogismo aristotelico o scolastico. C'è
nondimeno un elemento molto importante che non bisogna perdere di
vista: il radicamento dell' "anumana" nella percezione. Per gli
indiani, almeno per i "naiyayika", nei primi secoli di sviluppo
della dottrina, la relazione di inerenza tra lo "hetu" e il
"sadhya", cioè tra ciò che serve a provare qualcosa e la qualità da
provare, non deve essere considerata da un punto di vista puramente
logico, in termini di estensione, come implicazione di un termine
minore in un termine maggiore, ma vista piuttosto come il risultato
di un'esperienza.
In altre parole non si tratta di partire da premesse che sarebbero a
loro volta logicamente dimostrabili, perché generalmente le premesse
sono fornite in ultima istanza dall'induzione. E' la ripetizione
senza eccezione di casi simili, la compresenza per così dire
dell'elemento "fuoco" e dell'elemento "fumo" in determinate
circostanze, e la loro coassenza, la loro assenza congiunta in
altre, che porta in definitiva ad affermare il legame che li unisce.
Ma è sempre sospesa su un procedimento del genere una spada di
Damocle, perché non possiamo mai essere del tutto sicuri che la
nostra induzione sia stata completa. E soltanto più tardi, nel
quadro di un dialogo coi logici buddhisti, che i "naiyayika" hanno
progredito verso una vera teoria dell'implicazione logica,
propriamente detta, verso una teoria degli universali, ma per molto
tempo sono restati allo stadio che sto descrivendo.
Naturalmente il "nyaya" non si riduce a questo. Il "nyaya" è anche
una psicologia, una teoria dell'"atman", un'applicazione abbastanza
singolare per noi dell' "anumana" di cui ho parlato, alla
dimostrazione dell' "atman". Mentre nel "vedanta" questa
dimostrazione, come ho detto, precede l'uso dei "pramana", perché li
precede in linea di principio e in qualche modo li illumina -
bisogna che il soggetto sia dato, perchè i "pramana" siano
sviluppati dal soggetto - il "nyaya" non si inoltra su questa via e
crede di poter dimostrare l' "atman" allo stesso titolo di qualsiasi
altra realtà del mondo. Quindi parte anch'esso dai segni della
presenza dell' "atman", utilizza degli "hetu": la memoria, il fatto,
la coerenza del comportamento, eccetera, che non si possono spiegare
se non con la presenza dell' "atman". Anzi, il "nyaya" classico
accorda un'importanza preminente alla dimostrazione di un "Isvara" o
"Signore" che regge l'universo e fabbrica delle prove, che
assomigliano a quelle che saranno chiamate, nella nostra tarda
scolastica, prova cosmologica o "a contingentia mundi" e prova
fisico teologica, mediante le cause finali. Ci sarebbero molti
accostamenti da fare sotto questo punto di vista.
Un ultimo punto forse è da segnalare per quel che riguarda il
"nyaya". Il "nyaya" classico, a cominciare dal XIII o dal XIV
secolo, si è in qualche modo rinnovato. Ha abbandonato cioè i suoi
aspetti etici, metafisici o religiosi, ed è diventato una tecnica
estremamente raffinata e specialistica, ha raggiunto un grado di
formalismo assai spinto, chiamato "navyanyaya", letteralmente "nuovo
nyaya", che in quanto tale è servito poi da veicolo e si potrebbe
dire da gergo comune a tutte le altre scuole brahmaniche,
indipendentemente dal suo sviluppo proprio.
DOMANDA: E cosa ci può dire riguardo al
vaisesika?
Il "vaisesika", letteralmente, è la dottrina che verte sui "visesa",
cioè sui caratteri distintivi delle cose concrete, che incontriamo
nell'esperienza. Evidentemente è anche in un certo senso il gemello
del "nyaya", come lo "yoga" era il gemello del "samkhya". Non c'è
differenza profonda tra i due sistemi. Mentre il "nyaya" mette
l'accento soprattutto sulla teoria del ragionamento, sulle sue
condizioni di validità, il "vaisesika" si concentra prioritariamente
sull'analisi o sull'enumerazione delle categorie ontologiche. E'
chiaro che in ciò segue le analisi che i grammatici indiani, Panini
e altri, hanno proposto già da parecchi secoli, cioè la ripartizione
dei significanti in sostantivi, aggettivi, verbi, eccetera.
Il "vaisesika" traspone tutto ciò sul piano filosofico, distinguendo
le sostanze, analoghe dei sostantivi, le qualità o gli attributi,
ciò che può essere attribuito - gli aggettivi - , le azioni, ciò che
è indicato dai verbi, ai quali aggiunge i "tratti universali" o
"samanya", tratti comuni a cose diverse, i "tratti particolari", che
permettono di cogliere la singola sostanza e infine l'inerenza, il
"samavaya", la presenza di un'entità in un'altra. Certo ognuna di
queste categorie è suddivisa in parecchi e svariati modi.
Su questo punto però vorrei fare un'osservazione. In un certo modo
la dottrina delle categorie del "vaisesika" non può non evocare per
noi le dottrine delle categorie aristotelica e scolastica. Ci sono
tra quella e queste parallelismi evidenti. La differenza più
importante forse potrebbe essere questa: in Aristotele le categorie
sono veramente dell'ordine del leghein, cioè del discorso umano.
Sono i modi ai quali ci troviamo necessariamente vincolati, quando
vogliamo abbordare il reale, pensare il reale, e soprattutto dire il
reale. Aristotele non proietta immediatamente le categorie, non
realizza per così dire le categorie nell'esteriorità, non
attribuisce loro un'esistenza autonoma, a fianco alle cose che esse
servono a categorizzare.
Sembra che non sia questo il procedimento del "vaisesika". Il
"vaisesika" sembra professare consapevolmente o no, come il "nyaya"
del resto, un realismo profondo e credere a una specie di esistenza
in sè della sostanza, della qualità, dell'inerenza, eccetera, sullo
stesso piano delle entità che quelle categorie servono a
classificare. E' un fatto credo che merita di essere notato, anche
se non esaurisce l'ontologia del "vaisesika".
Noi possiamo, sia pure in modo singolare, continuare il parallelo
con Aristotele: praticamente il "vaisesika" è la sola scuola,
nell'India antica, che ha prolungato la sua teoria delle categorie
del reale, con una fisica a priori dello stesso tipo di quella che
troviamo in Aristotele, cioè una teoria del tempo, del luogo, dello
spazio, del movimento, interamente deduttiva e del tutto estranea ad
ogni forma di esperienza. Tuttavia ciò che è più notevole nel
"vaisesika" è la forma che dà un certo modo di intendere la realtà
sensibile esterna, la materia, largamente diffuso in India, ma che
trova qui la sua più precisa formulazione e cioè la teoria
atomistica, la teoria che considera tutta la materia esterna
composta di atomi, nella fraseologia del "vaisesika" di "parama
anu". "Anu" vuol dire "minimo", estremamente sottile, "parama"
significa "ultimo": quindi gli "estremi della piccolezza".
Si potrebbe fare anche un parallelo con l'atomismo greco. E' certo
che "parama anu" è qualcosa di indivisibile, che non può essere
ulteriormente scomposto e tuttavia deve avere una certa estensione
nello spazio, in mancanza della quale la combinazione di entità
prive di volume, prive di dimensioni, non produrrebbe in alcun modo
delle entità macroscopiche. C'è tuttavia una grande differenza:
mentre Democrito per esempio ammette atomi di una sola specie e
pensa alla formazione dei vari generi di materia e di corpi, come
risultato delle differenti combinazioni tra gli atomi, il
"vaisesika" in sostanza non si spinge così lontano e ammette che
esistono atomi di acqua, di terra, di aria e di fuoco. All'interno
di ciascuno di questi quattro grandi gruppi, di questi quattro
grandi ordini di materia, l'organizzazione della materia è spiegata
un po' allo stesso modo, per formazione di composti binari. Quei
composti poi si associano a due a due, formando delle terne,
eccetera, fino a raggiungere un primo livello di visibilità della
materia, il "trasarenu", letteralmente il pulviscolo che si
intravede in un raggio di sole. A questo punto si è passati dal
livello atomico a quello macroscopico, alla sfera del visibile. C'è
dunque tutta una fisica del "vaisesika" abbastanza notevole, della
quale ho potuto dare qui solo qualche cenno.
Per finire credo che si possa mettere in luce l'importante
contributo del "vaisesika" alla teoria delle funzioni mentali e
soprattutto alla teoria dell'attenzione e della percezione
sensibile. Ho detto prima che era una teoria delle sostanze e che
era anche una teoria atomistica. Ora, ne esiste una applicazione
alquanto singolare al rapporto tra l'"atman" - che il "vaisesika"
riconosce al pari del "nyaya", - e tutte le strutture mentali che
gli servono a entrare in rapporto con il mondo esterno, in
particolare il "manas", quella specie di senso comune, di
coordinatore dell'attività dei sensi, che sia il "samkhya" che lo
"yoga", sia il "nyaya" che il "vaisesika" ammettono. E la
particolarità del "vaisesika" è di affermare che la struttura del
"manas" è atomica. Perché una determinata percezione abbia luogo, o
anche un'immagine, l'immagine di un particolare oggetto si formi, si
deve stabilire una congiunzione, grazie a una serie di contatti tra
l'oggetto esterno, l'organo di senso che serve a veicolare il
messaggio verso il "manas", il "manas" stesso e l' "atman".
In questa prospettiva in cui si suppone che il "manas" è atomico,
quindi estremamente piccolo ed estremamente mobile, il "vaisesika"
afferma che non possiamo porre attenzione a più di un oggetto per
volta, perché la congiunzione tra l'oggetto e l' "atman", tramite il
"manas", non può essere che una congiunzione semplice, come se il
"manas" fosse un cavo telefonico a una sola pista, che può portare
un solo messaggio alla volta. Ne deriva tutta un'analisi della
percezione, dell'attenzione, condotta in questa prospettiva.
Ogni volta che abbiamo l'impressione di essere attenti a una serie
di oggetti presi per sé, per esempio quando guardo davanti a me e
vedo persone e cose o concentro l'attenzione su quello che dico, per
il "vaisesika" si tratta più propriamente di un andirivieni
rapidissimo del mio "manas", che un momento si fissa su un dato
visivo, il momento dopo su un dato auditivo e dopo ancora su una
traccia recata dalla memoria. Il paradigma, l'esempio che si porta
per far capire questa situazione, è quello delle cento foglie di
loto, strette insieme e trapassate da un sol colpo di spillo. E'
evidente che lo spillo traversa successivamenmte ognuna delle cento
foglie, ma il colpo è così istantaneo, che per il senso esterno è un
solo e stesso atto.
Questo è solo un esempio della sottigliezza cui perviene il
"vaisesika", quando prolunga la sua fisica, la sua psico-fisiologia,
nell'analisi delle funzioni mentali. In altri campi la sua
originalità è assai relativa. Come il "nyaya" anch'esso dimostra l'
"atman" mediante l' "anumana" o "inferenza", e ugualmente mediante
l' "inferenza" dimostra l'esistenza di un "Signore", creatore e
reggitore dell'Universo; ma in ciò che concerne la sua teoria della
liberazione, come il "nyaya" è assai povero, è assai limitato. A
differenza che nel "vedanta", dove l' "atman" possiede
fondamentalmente delle qualità positive, come la luminosità,
l'onnipotenza, la beatitudine, eccetera, nel "vaisesika" e nel
"nyaya" l' "atman" per sé ha bisogno di entrare in contatto con i
sensi, di entrare in contatto col mondo esterno tramite i sensi, per
conoscere o provare qualsiasi cosa, sicché il modo di intendere la
liberazione che ne consegue è del tutto negativo. La liberazione è
intesa come fine della trasmigrazione, come fine dell'unione con un
corpo e conseguente ripiegamento su di sé di un "atman" che non è
piu' veramente cosciente, che lo è solo potenzialmente, ma lo
diviene nella forma di questa o quella esperienza particolare.
Dunque per definizione non ha più nulla da vedere, nulla da
immaginare, nulla da pensare, nulla da sentire, ed è inerte come una
pietra. I testi dicono letteralmente: "come una pietra".
Questa concezione prova che la preoccupazione per la liberazione non
è essenziale a questo modo di intendere, che è volto piuttosto al
mondo esterno e a dare una spiegazione plausibile dei nostri
conflitti col mondo esterno nell'ordine della conoscenza e
dell'azione.
DOMANDA: Siamo
arrivati all'ultima domanda: che significato hanno oggi i
"darsana" per il pensiero occidentale contemporaneo?
Si potrebbe pensare che i "darsana" siano superati, che appartengano
al passato, ma credo che le cose non stiano veramente così. Si
possono individuare diversi ordini di significato, procedendo dal
piano più esterno verso il più interno. Se consideriamo lo stato
attuale della filosofia, delle problematiche filosofiche, risulta
subito evidente per esempio che il fenomeno del linguaggio,
l'analisi del linguaggio è al centro delle sue preoccupazioni.
Non soltanto lo strutturalismo, ma la filosofia analitica
occidentale e in qualche modo anche la fenomenologia tornano
all'esigenza di determinare il senso esatto delle parole, per
cogliere la genesi del senso attraverso la concatenazione delle
parole, e di trovare il referente genuino di una determinata
enunciazione. È evidente che queste preoccupazioni che sembrano
assai recenti, che sono emerse negli ultimi venti o trenta anni,
forse negli ultimi quaranta, nel pensiero occidentale possono
trovare una specie di prefigurazione, di maturazione precoce nelle
speculazioni alle quali si sono dedicati i "darsana", in particolare
la "mimamsa", ma anche, a suo modo, il "nyaya" e perfino il
"vedanta", nella continuità dell'esegesi vedica. E' lì che ci si è
interrogati per la prima volta sul rapporto tra significante e
significato, che ci si è chiesti se termini isolati possano avere
per sé un significato o se lo acquisiscano soltanto quando si
trovano collegati nel contesto di una frase.
E' di un interesse forse archeologico, ma certo non trascurabile,
l'anticipazione, presente in altre culture, di preoccupazioni che
nella nostra sono emerse a una data relativamente recente. E'
evidente inoltre che ciò che caratterizza la ricerca moderna nella
maggior parte delle correnti filosofiche contemporanee è - per via
di negazione - la rinuncia a far apparire la filosofia come
produttrice di - o come una promessa o un invito ad accedere a - un
regime mentale nuovo. In altri termini la filosofia come via alla
saggezza, nonostante il suo nome, è qualcosa cui la maggior parte
delle correnti attuali ha rinunciato.
La filosofia tende sempre più a considerarsi come una disciplina
specializzata e si trova poi in imbarazzo a dire in che cosa
consiste esattamente questa specializzazione, mentre per un altro
verso è ormai solo in casi eccezionali che si pensa come disciplina
di vita, come ricerca, per via di riflessione, di una forma di
saggezza in accordo col mondo.
Io credo che lo studio dei "darsana", e in generale delle dottrine
indiane, può richiamarci all'evidenza che le cose non stanno
necessariamente così. In altri termini noi cerchiamo di colmare la
lacuna che avvertiamo oggi - ovvero questa abdicazione della
filosofia, che mostra di non tendere più alla saggezza - con il
ricorso a istanze diverse, per esempio alla psicanalisi e ai suoi
derivati, o con il ricorso a maestri spirituali che ci vengono da
altre civiltà.
Lo studio della tradizione indiana classica sembra indicarci che
quel divorzio tra filosofia e saggezza non è obbligatorio e che nel
campo dei "darsana" c'è una continuità armonica tra le
preoccupazioni d'ordine epistemologico, gnoseologico, tra la teoria
del sapere, la teoria della scienza e le vere finalità di quelle
ricerche: non un comprendere, fine a se stesso, uno studio delle
funzioni mentali per se stesse, ma un comprendere la loro ragion
d'essere ultima, le condizioni di possibilità che permettono allo
spirito di accedere a uno stato diverso, in una parola a ciò che
tradizionalmente si chiama salvezza.
Credo che l'ambizione propria della filosofia, ancora forte al tempo
dei Greci, abbandonata a poco a poco nell'età moderna, e quasi
dimenticata oggi, può rinascere dallo studio dei "darsana", non
nella forma di una imitazione servile, ma nel contatto con la
tradizione viva che ce li trasmette.
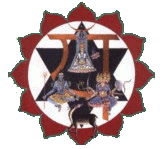 |
Associazione
Centro Yoga Anahata
Via Scalabrini 19/21 (Ospizi Civili), 29122 Piacenza http://www.centroanahata.org ............e-mail: info@centroanahata.org contatti: .339 270 9918 (cell. Silvia) - 0523 336715 (segr. tel.) |
 |



